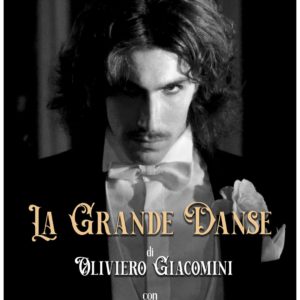Il 21 settembre è tornato in sala The Elephant Man, opera seconda scaturita dal genio visionario di David Lynch. Action Academy, ovviamente, lo ha visto per voi e qui ve lo ripropone attraverso le forti impressioni e le belle parole di Alessandro Rovito, arrembante regista e sceneggiatore “covato” nel caldo nido del nostro corso di creatività e produzione. Buona lettura e buona visione.
« La pellicola ha vissuto il suo debutto 40 anni fa, precisamente il 3 ottobre del 1980 (in Italia arrivò il 6 marzo dell’anno successivo), mentre oggi rivede la luce grazie al restauro operato da StudioCanal e alla distribuzione della Cineteca di Bologna. Quest’edizione restaurata si rende tanto più necessaria oggi, in cui la paura del diverso continua a imperversare nella società: porti che vengono chiusi e muri che vengono innalzati non fanno altro che ricordarci quanto possa essere triste e disumano l’allontanamento di persone diverse da noi, di chi non rientra in un determinato spettro di caratteristiche culturali e fisiche. Come ci ricorda il protagonista del film di Lynch, l’uomo ha paura di ciò che non riesce a capire: uno sforzo per comprendere e accogliere la realtà di chi non ci è simile sarebbe quindi opportuno, allo scopo di uscire da un clima di diffidenza intrinseco nell’uomo e che il fattore esterno del coronavirus non ha fatto altro che accentuare in questo 2020 devastante.
Al di là del messaggio
Per quanto il messaggio implicito in The Elephant Man, messaggio di integrazione e accettazione della diversità, sembri pensato apposta per l’attuale fase di chiusure e discriminazioni che stiamo vivendo oggi, sarebbe assolutamente limitante fermarsi a questa natura morale della vicenda narrata, perchè il valore vero di quest’opera è stato e sempre sarà la sua “liricità”, il senso profondo e doloroso di poesia che emana. Ai tempi della prima uscita in sala il pubblico rispose in maniera molto positiva, tanto che questo film resta ancora oggi il maggior successo commerciale del regista di Missoula (Montana). Altrettanto bene rispose la critica, anche se alcuni accusarono l’autore di essere troppo retorico e classico, critiche che potrebbero aver orientato il giovane Lynch a seguire quella strada di folli sperimentazioni e visionarietà che poi diventerà la sua cifra inconfondibile. Il film ottenne per altro otto nomination agli Oscar, tra cui quelle per miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista al compianto John Hurt. Questo è il segno evidente che, al di là dell’edificante avviso a comprendere e accogliere il diverso, la pellicola fa breccia nel cuore dello spettatore grazie alle manifestazioni di cultura e alla poesia di cui è composta.

La bestialità secondo Lynch
John Merrick (il cui vero nome era Joseph) è nato con una grave deformità, un aspetto che di umano ha ben poco a causa della sindrome di Proteo (il dio greco mutaforma). Questa condizione lo ha portato nelle grinfie di un malvagio uomo di spettacolo, che lo schiavizza, insieme ai molti altri freak, sfruttandoli come attrazioni in un lucroso (ma solo per lui) spettacolo di “mostri umani”. Il protagonista diviene così l’Uomo elefante, uno scherzo della natura da cui gli altri possono trarre ricchezza e divertimento. Tutto ciò può assimilare il film di David Lynch ad uno dei più famosi classici Disney, Dumbo: la rappresentazione dell’elefante, il contesto circense, l’emarginazione sociale legata a ciò che si ritiene essere una “deformità” (l’aspetto di Merrick, le orecchie di Dumbo) e l’amore materno sono gli ingredienti che creano un impensato ponte fra le due opere. Lynch ovviamente compie un passo in più perché non gli basta dichiarare la componente animalesca e la reputazione elefantina del povero Merrick. Ci costruisce attorno un’aura di mistero, suspense e imprevedibile fantasia che è tutta “iconica”, filtrata attraverso immagini di grande impatto visivo, proprio come nella sua famosa serie televisiva. Il film, infatti, si apre con la madre di Merrick che soffre in alcuni spaventosi primi piani. Al viso dell’attrice si alternano inquadrature di elefanti, che caricano minacciosi e agitano la proboscide come a volersi impossessare della sessualità della donna. Si tratta di un richiamo alla mitologia greca: Pasifae si congiunse in una mostruosa unione con il temibile toro che imperversava nelle terre di Creta, e da quell’innaturale relazione nacque nientemeno che il Minotauro. Lynch cerca di riproporre questa stessa mitologia attraverso la sua creatura, almeno idealmente: metà uomo e metà elefante, John Merrick risulta essere il frutto di un incidente della natura. L’intento è chiaro: ci si appresta a guardare la storia di un essere visto da tutti come una minaccia, ma che in realtà ha anch’esso diritto di esistere. Tanto più che l’Uomo elefante è tutto l’opposto del furioso Minotauro: egli è placido, gentile, succube, privato del mondo, dietro il mostro lascia vivere e respirare un uomo triste e silenzioso. In Merrick è la componente umana a prevalere su quella animalesca, e quando non è più sufficiente dimostrarlo con i fatti (l’ingresso nella società e l’amicizia con chi si prende cura di lui) arriva il momento in cui John lo dichiara prepotentemente con le parole, nella famosa scena in cui per scappare al linciaggio da parte di una folla urla “io non sono un elefante, io non sono un animale, sono un essere umano”. Un uomo.

L’amore di una madre
Per diventare uomini bisogna essere amati. Merrick può contare sull’amicizia del suo salvatore e mentore, il dottor Frederick Treves, e sull’affetto del personale dell’ospedale e delle persone che lo ammirano sinceramente, come l’attrice Madge Kendal. Ma il primo amore ricevuto da John, come per qualsiasi bambino, è quello della sua mamma. L’amore dolente di una madre che ha visto il proprio figlio tramutarsi in qualcosa di pericoloso, e non certo per conto suo, ma a causa di una società che non può dare spazio al diverso. Se l’Uomo elefante ci fa piangere pensando a quanto gli manchi sua madre, non possiamo fare a meno di pensare a quanto abbia pianto la sfortunata donna che sapeva di morire lasciando il figlio da solo in un mondo che non lo avrebbe accettato e che gli avrebbe fatto del male. L’impotenza di un genitore di fronte alle difficoltà della propria creatura è qualcosa di straziante, e in The Elephant Man questa tematica scorre sotterranea ma affiora ogni qual volta John ricorda la bellezza della madre crucciandosi pensando di non averla resa fiera. Queste scene di ricordo sono come isole di dolcezza all’interno del film e del mondo feroce che costruisce tutto in torno e rendono il tema della relazione filiale uno dei più toccanti e umanamente partecipati di quest’opera stratificata.
Al di fuori di questa dimensione pacificata che è la relazione affettiva con la madre, tutto il resto è “conflitto”: conflitto con la società, conflitto con quei suoi simili, gli umani, cui vorrebbe piacere ma che lo rifiutano costantemente, e, ancora di più, conflitto “interiore”, conflitto del protagonista con se stesso, con i demoni che abitano la sua psiche. Demoni che diventano quelli di ognuno di noi, quando il film ci obbliga a chiederci se, nella stessa situazione, noi stessi riusciremmo a proteggere i nostri cari da quello che può essere il nostro lato bestiale, e se riusciamo a renderli orgogliosi del nostro lato umano. È il momento in cui l’Adagio per archi di Samuel Barber che fa da sottofondo alla malinconica morte di John Merrick dilania il cuore già straziato dello spettatore: in una struttura circolare si ritorna a vedere il volto della madre, come se da lontano avvertisse la dipartita del figlio e gli dicesse che tutto il dolore e la tristezza provati avranno una compensazione mistica da qualche parte del mondo. All’inizio mitologico del film corrisponde così un finale metafisico, rendendo evidente come lo stile visionario di Lynch non sia stato accantonato in questa pellicola dall’impostazione classica.
Lo sguardo dello spettatore Lynch esegue un’altra operazione estremamente intelligente. Il protagonista non appare prima di un quarto d’ora abbondante di film. Nel frattempo l’attenzione è focalizzata sul dottor Treves, interpretato da un ottimo e commovente Anthony Hopkins. Invece di giocarsi da subito l’effetto shock della visione del mostro Lynch, con un senso dell’attesa a dir poco hitchcockiano, costruisce tutta una prima parte completamente incentrata sulla identità del presunto mostro, tutte le ricerche del professore che continuamente lo chiamano in causa, senza però mai mostrarci Merrick direttamente. In questo modo crea un forte senso di mistero e di attesa nello spettatore riguardo al suo aspetto e alla sua identità che protrae per lungo tempo, in modo da fargli vivere l’arrivo della prima visione di quel volto deforme come una vera e propria rivelazione. Le indagini in cui il chirurgo londinese si addentra per trovare e conoscere l’Uomo elefante sono caratterizzate da un interesse scientifico prima che umano, fatto che lo porterà a rimettere in discussione la propria tenuta morale, la bontà d’animo che inconsciamente si era sempre attribuito in conflitto con l’impulso egoistico dello scienziato in carriera che lo portava a vedere in Merrick solamente “un caso” di studio eccezionale. Quella che nasce in seguito tra i due, però, è una vera e disinteressata amicizia, altro solido baluardo che Lynch contrappone all’emarginazione per dare una sparuta boa di salvezza al povero Merrick. Il Dottor Treves diventa metafora assoluta dello spettatore. Spinto inizialmente a conoscere l’Uomo elefante, l’oggetto misterioso e meraviglioso al pari del film, dalla curiosità del conoscere vedendo, curiosità puramente cinefila, poco alla volta, esattamente come lo spettatore, prende coscienza della sua triste vicenda e finisce per empatizzare con lui, per comprendere il suo dolore nello stesso modo con cui succede a noi che siamo in sala. Lo sguardo dello spettatore si riflette in quello di Frederick che versa delle lacrime di fronte alla sciagura dell’uomo deforme. Treves e Merrick diventano complementari: il dottore, il lato umano del binomio, riesce a trovare il significato della propria esistenza aiutando il fratello più sfortunato di lui; l’Uomo elefante, la parte animalesca della coppia, raggiunge la felicità che mai avrebbe provato se non avesse reso Frederick un uomo completo. Razionalità ed emotività vengono a legarsi, lasciandosi alle spalle i residui di una bestialità di cui entrambe hanno bisogno di liberarsi.

L’edizione restaurata
I vantaggi che il restauro presenta in questa nuova edizione per le sale cinematografiche sono diversi. Innanzitutto si può apprezzare meglio il favoloso trucco di Christopher Tucker, che ha riprodotto fedelmente l’aspetto deforme di Merrick applicandolo al fisico e al volto di John Hurt. Inoltre il bianco e nero della pellicola rende ancora più vivida la Londra vittoriana che fa da sfondo alla vicenda dell’Uomo elefante, restituendo pienamente la degradazione di una città impossessata dalle macchine e dall’industria. Questo ritorno nelle sale è l’occasione unica di godersi al pieno un capolavoro della settima arte, sia dal punto di vista della sceneggiatura che della resa artistica. Impossibile non commuoversi riguardando al massimo del loro splendore gli occhi trisi e ingenui di John Hurt/Merrick.»