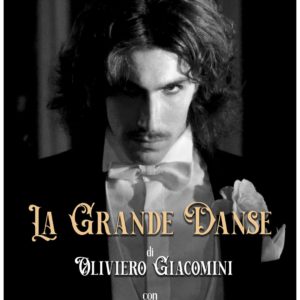RESIDUE (Merawi Gerima)
Per Le Giornate Degli Autori abbiamo visto Residue di Merawi Gerima, opera sorprendente anche se in parte derivativa, nel senso che consapevolmente si mantiene entro un orizzonte di riferimenti stilistici
piuttosto ricorrenti per quel cinema che si pretenda se non propriamente sperimentale quantomeno alternativo. Ma ben aldilà di questa non completa originalità delle forme Gerima si dimostra abilissimo nella creazione di una stilistica estremamente personale e funzionale alle proprie urgenze espressive. Jay ritorna a casa, la vecchia Q street, strada Q del suo vecchio quartiere di Washington DC dopo più di 13 anni di assenza. Ma il quartiere è cambiato: «molti bianchi si sono trasferiti qui ormai» gli dice uno degli ubriaconi che stazionano allo stesso angolo di quando lui era bambino dopo averlo riconosciuto. Una nuova borghesia, bianca e benestante, sta imponendo il proprio giogo sui vicoli teatro delle scorribande del Jay ragazzino. Gli afroamericani che una volta abitavano per intero il quartiere, quasi sempre indietro con l’affitto, vengono via via espropriati di case subito demolite per edificare le nuove e lussuose dimore
dei nuovi arrivati. Si respira discriminazione ad ogni angolo. Jay era tornato per girare un film che desse a questi oppressi una voce , un film sul quartiere, un sogno estetico, da ragazzo che dalla morsa del ghetto ha potuto liberarsi e studiare all’università, ma è un sogno destinato a rivelarsi in tutta la sua impraticabilità in questa dimensione in cui a nessuno importa di avere una voce preoccupati come sono di arrivare vivi alla mattina successiva, di non perdere la casa, di scampare all’ennesimo pestaggio della polizia. «Mister università» così lo chiamano i ragazzi del getto, lui che è potuto andare alla Columbia University, diventando senza volerlo un diverso per qui vecchi amici di scorribande segnati dal destino unico e senza possibilità di ritorno che appartiene a tutti quelli del quartiere. «sei venuto qui con la sola arma che hai sempre avuto, la tua telecamera, ma che ti credevi? che un film poteva salvarci?» il destino
fallimentare del film di Jay non è diverso da quello dei vecchi amici che reincontra poco alla volta. Storie di armi e droga, di violenza e destini senza via d’uscita. Demetrius, l’amico di un tempo, il suo protettore e modello risulta introvabile e le sue tracce coperte dall’omertà degli abitanti del quartiere, Dion, l’altro amico-fraterno é in carcere, e lo stesso destino seguono via via tutti gli altri perché a quelle latitudini qualsiasi tentativo che non sia mera sopravvivenza, qualsiasi sforzo per rialzare la testa è destinato a finire male. Ma il ghetto non è solo una provenienza, è una maledizione che ti si attacca al sangue, qualcosa da cui non si sfugge neanche quando gli studi all’università ti hanno ripulito ed elevato e di fronte all’ennesimo sopruso perpetrato dell’ennesimo anonimo arrogante Bianco, anche Jay non potrà più quel sottrarsi a quel destino comune, e finirà come i suoi amici.
Ben oltre la trama, dolorosa, ma non originalissima, che di storie simili ormai ne abbiamo sentite tante, ciò che più colpisce veramente è la veste stilistica di questo esordio cinematografico, che con grande abilità rimescola regimi stilistici differenti e differenti piani temporali in un intreccio impattante e lirico al contempo. Deformazioni del visivo, frammentazioni del sonoro, sfocature forzature dell’immagine che ci restituiscono oniricamente e secondo una sensibilità fortemente espressionistica i ricordi, di Jay, i suoi continui ritorni al passato, che però, in una struttura di alternanza continua, si interpongono a momenti di un realismo crudo, che restituisce Il quotidiano del ghetto, la vita in strada in tutta la sua ottusa violenza. L’impasto che ne emerge è ammaliante e contundente, tanto più che sul piano tematico invoca a riflessioni di un certo peso. La gentrificazione che divorando i vecchi quartieri divora anche gli stili di vita, i precari equilibri relazionali che ne erano parte integrante al pari delle case, l’esplosione di coscienza nel movimento Black Life Matters, la sua deriva degenere e violenta, la criminalità delle strade che diventa la sola forma di vita praticabile per chi non trova altre possibilità di crescita sociale, la sperequazione economica senza possibilità di riscatto che affligge i ceti più deboli della società americana, la discriminazione razziale. Un film intenso e potente per impianto percettivo che in più, nella continua dialettica tra la finzione del film di Jay e la sorda violenza del reale quotidiano, innesca la possibilità di una lettura disegno metalinguistico. Davvero da vedere.
DASHTE KHAMOUSH
(Terra Desolata- di Ahmad Bahrami)
È un Iran acromatico e poverissimo quello che Ahmad mette in scena, lontanissimo dalla più convenzionale iconografia cinematografica mediorientale assolata e dai colori accesi, un Iran in uno stupendo bianco e nero, disseccato da un costante vento rovente, riarso di polvere arida che spira in folate. L’Iran degli ultimi degli ultimi, i lavoratori indigenti e sfruttatissimi di una miseranda fabbrica tradizionale di mattoni, dove ogni singolo pezzo ancora viene modellato a mano lavorando l’argilla e la
cottura avviene in un vetusto forno a legna. Soffocato dalla concorrenza del cemento e del calcestruzzo, il malandato stabilimento è ormai in procinto di rendere l’ultimo respiro e l’obiettivo di Bahrami ocularizza i drammatici momenti che seguono il discorso tenuto dal proprietario per l’occasione e
congedare gli operai. La prima metà del film è tutta corale e segue le storie di vari di questi operai, in cui la costante è la pandemica necessità di tutti di trovare denaro. Per dare a una figlia un futuro diverso, lontano da quella polvere e quel vento, per fuggire con la propria amata e sognare un destino migliore oppure per riscattare la vita di un padre condannato a morte. Tutti hanno un sogno, e tutti i sogni hanno un costo, e tutti i protagonisti, immancabilmente, finiscono per convergere nell’ufficio del capo, detentore
unico del potere economico. Qui si consuma il balletto antico dei servi e dei padroni, che poi forse è il significato principale di questa elegia desertificata, in cui il padrone, elegante e protervo, promette e blandisce, vagheggia di introiti sempre imminenti per sistemare tutto, millanta conoscenze giù in città in grado di sanare qualsiasi contrarietà e i servi, gli sfruttati, oramai adusi alla sottomissione, non possono fare altro che fidarsi, accettare, acconsentire sempre ad un ulteriore, umiliante, compromesso. La litania ancestrale del potere economico che da secoli si ripete uguale a sé, senza possibilità di variazioni, come quel monotono soffiare del vento che in sottofondo abita ossessivamente le inquadrature. Tutta la seconda parte del film invece è dominata dalla figura di Lotfollah, l’operaio anziano, «che ha lavorato in questa fabbrica per più di 40 anni» che ha funzione di capo degli operai e intermediario presso il padrone. Figura doppia, che da un lato ordisce trame, mette gli operai gli uni contro gli altri, e tutti contro il padrone, ma che dall’altro media il contrasti, aiuta i poveracci a trovare soluzioni pratiche ai loro problemi. Tutta questa seconda porzione del film, in cui ormai tutti gli altri operai se ne sono andati, segue il solo Lotfollah che rimasto solo dovrà chiudere, come in una sorta di ritualistica funebre, la fabbrica ormai vuota che rappresenta tutta la sua vita. Ahmad Bahrami è stato allievo di kiarostami, e con questa sua opera seconda dimostra di aver appreso bene dal maestro l’idea di un cinema intenso, gravido di senso pur nella estrema rarefazione di uno stile sempre essenziale e lontano dagli eccessi hollywoodiani. Tutta la prima parte, quella corale, è narrata secondo una interessante struttura “per cicli” in cui ogni ciclo narrato corrisponde all’episodio relativo a un diverso personaggio. Ogni episodio prende il via dal discorso che il proprietario tiene per annunciare la chiusura dello stabilimento. La macchina da presa ad ogni nuovo ciclo individua un personaggio nel gruppo degli operai che ascoltano sgomenti e lo segue in via prioritaria durante il proprio colloquio col padrone e successivamente nelle rispettive case. Ogni episodio si conclude con il protagonista che si stende per dormire coprendosi interamente con un lenzuolo bianco che metaforicamente rimanda al sudario sepolcrale. Poi, con un salto indietro nel tempo, si ritorna al discorso del proprietario per poi seguire un personaggio nuovo. La soluzione non è originalissima ma certo conferisce dinamismo movimento alla narrazione. Molti sono i significati che a che affiorano a margine di questa biblica epopea dei diseredati: la denuncia delle inumane condizioni del lavoro in quelle terre, l’attenzione per i conflitti etnico culturali che si condensano nelle frizioni tra operai libanesi e curdi, la condizione orribilmente oppressiva delle donne, rigidamente comandate da questi uomini comandati a loro volta, le quali tuttavia sono le uniche a non credere alle menzogne del padrone dimostrandosi ben più assennate e capaci di valutazione oggettiva dei loro uomini-padroni. Insomma un film intenso e gravido di significati, che però non si propone come film per tutti.
Terra desolata è infatti un film di lunghi silenzi abitati solo dal soffio del vento e dal rumore incessante del lavoro umano, il suono della fatica e unico segnale di viva presenza in quel deserto. Un film in cui l’intensità, si condensa in lunghe inquadrature fisse sapientemente costruite in un ritmo lento che ha la solennità del racconto biblico. Un film senza eroe ne colpi di scena, che per queste ragioni sembra poco adatto al grande pubblico in cerca di intrattenimento facile, ma che può regalare grandi momenti di
intensità allo spettatore più attento e paziente.
LACCI (Daniele Lucchetti)

Lucchetti nel raccontarci questa storia di sentimenti, di distacchi e riconciliazioni familiari che dipana su un arco di 30 anni, collocandosi tra meló e introspezione psicologica, opera preliminarmente una scelta di campo precisa, che è quella di non fuoriuscire dalla comfort zone di un cinema narrativo, e forse di più, di quel cinema narrativo tipicamente italiano, iniziato coi vari Salvatores e Tornatore, che cerca con alterni
esiti di non smarrire almeno le residue scorie di autorialità. Attenzione perché dire cinema narrativo non significa semplicemente designare un cinema che per argomento ha una storia, significa soprattutto voler
indicare un modo preciso di utilizzare e orientare lo stile del film. Narrativo, infatti, è quel film in cui tutti i vari codici e sottocodici stilistici del film, le sue scelte in fatto di montaggio, il modo in cui vengono scelte le riprese, le angolazioni di macchina, le luci, e via dicendo, tutti saranno subordinati al racconto di questa storia, al renderlo più fluido, chiaro, ritmato e coinvolgente per lo spettatore, mettendo magari da parte quegli eccessi, dell’immagine e dello stile che potrebbero distogliere il pubblico dalla comprensione e immedesimazione nella trama. Ed è proprio questo che Lucchetti fa, adotta uno stile registico trasparente, che tenda a scomparire dietro alla storia che racconta, cercando di non farsi troppo notare. Se non si fa questa premessa metodologica se non si capisce che a priori questo film non deve essere guardato con le medesime aspettative con cui si guarda ad opere dal programmatico intento artistico-autoriale come le Le Livre d’image di Godard o i film di Maresco, si corre il rischio di porsi secondo una prospettiva che non permette di cogliere il valore di quest’opera. Unica licenza poetica che Lucchetti si concede come regista è quella di un montaggio a incastro della storia, che si sviluppa contemporaneamente su piani cronologici differenti, gli anni 80 in cui i personaggi ancora giovani vivevano un rutilare di sentimenti e passioni, e il presente in cui tutti fanno i conti con la propria trasformazione dovuta al tempo, con gli avanzi scarnificati di quei sentimenti una volta vivi. La messa in scena, dettagliata e credibilissima nella resa storica di quegli anni, e la narrazione procedono dunque con stile realistico, senza impennate o sorprese, impegnandosi più che altro nel restituire al meglio le performance degli attori con mirati primi piani. E proprio sulle qualità recitative del cast stellato poggia buona parte della riuscita di questo film. Alba Rohrwacher, che per stereotipo associamo a quel tipo di recitazione soffiata, realizzata a fil di voce, che ce l’ ha resa nota in film come Il Papà Di Giovanna, qui porta a maturazione un diverso filone della sua ricerca espressiva e corporea, più dinamico e vivace sotto il profilo della espressione emotiva, che aveva iniziato a vedersi già da Perfetti Sconosciuti. Ne risulta una parte di moglie abbandonata, single madre, ragazza tradita nelle speranze, a tratti nevrile e a volte sognante, amara e innamorata, dura e fragile, che rimane nel cuore. Anche Lo Cascio si trova perfettamente in parte nella restituzione di questo personaggio schivo e introspettivo, che ben si incarna nella sua recitazione spesso fatta di segnali ed espressioni minime, di quasi impercettibili variazioni, e che fisicamente si ritrova in quella sua naturale espressività un po’ accigliata, cupa e riflessiva. Che Silvio Orlando stia attraversando un periodo di stato di grazia è fuor di dubbio, lo dimostrano le sue più recenti apparizioni filmiche. Il suo Cardinale nelle due serie firmate da Sorrentino The Young Pope e The New Pope è un vero gioiello di caratterizzazione e misura interpretativa. In Lacci questa sua vena non viene meno e gli fa portare sullo schermo un personaggio di uomo maturo, quello che in gioventù interpretava Lo Cascio, vibrante, agitato dai molti rimpianti, sensi di colpa e prese di coscienza che gli anni stratificano. Deliziosa anche Linda Caridi, nella parte dell’amante di Lo Cascio da giovani, adeguata nella parte di questa giovane donna dal carattere scoppiettante ed entusiasta della vita, ma anche consapevole. La sua bella presenza inevitabilmente richiama alla mente Ricordi? di Valerio Mieli di cui fu coprotagonista con Luca Marinelli passato alle giornate degli autori nel 2018, che è film simile a Lacci per piglio emotivo e psicologico, forse però più lirico sul piano onirico e fotografico. Tosta, da pugni allo stomaco, la mezzogiorno nella parte della figlia ormai matura e segnata dalla vita, anche se la sua parte come quella che interpreta Giannini figlio, suo fratello anch’esso ormai maturo, sembrano essere meno giustificate a livello di scrittura e meno incorporate nel resto dell’intreccio coerente. Bella e notevole Laura Morante, che interpreta la moglie in fase matura, quella che da giovane era interpretata dalla Rohrwacher, che con un’espressività risentita, acre, recita con efficacia quella fase biliosa della mezza età delusa, della moglie stanca e amareggiata. Insomma un film ben congegnato e ben girato, ancor più splendidamente recitato, cui forse, anche per una consapevole scelta registica di Lucchetti che si mantiene a una certa distanza dalle punte emozionali, manca solo un piccolo gesto di coraggio in più, il coraggio di una variazione formale sorprendente che accenda la meraviglia del cinema o di una qualche emozione più contundente, un piccolo graffio o un pugno nello stomaco. Resta comunque un opera piacere ad un pubblico più esteso e propenso all’emozione introspettiva.
MISS MARX (Susanna Nicchiarelli)
È un film difficile da valutare questo della Nicchiarelli, che sottoposta a riflessione postuma forse lascia emergere un livello di stratificazione ben superiore a quello che di primo acchito appare. Dopo la poesia decadente ed rockettara di Nico 1988, miglior film nella sezione Orizzonti 2017, Susanna Nicchiarelli porta sullo schermo un’altra figura di donna eccentrica, combattiva ed anticonformista, Eleanor Marx figlia minore del padre del socialismo Karl. Paladina dell’egualitarismo sociale questa giovane donna combattiva e coltissima portò avanti con determinazione i principi paterni impegnandosi come paladina della lotta al lavoro minorile e antesignana delle battaglie per il riconoscimento dei diritti della donna. Un’anima eversiva, una sensibilità punk ante litteram insofferente alle stringenti convenzioni sociali e capace di scardinare la logica delle regole imposte, come ben sottolineano le scelte musicali della Nicchiarelli, spesso sorprendentemente schitarrozzate e distorte. Una intuizione veramente brillante questa della musica Punk, che richiede una certa dose di coraggio, visto che, in barba a qualsiasi convenzione sulla corrispondenza storica tra le musiche e l’epoca di ambientazione del film, potrebbe fruttare alla regista l’accusa incoerenza. Ma d’altronde lo scopo che si era data era quello di trovare una musica che esprimesse “l’essenza”, l’anima vera del personaggio, non quella di creare una perfetta coerenza filologico musicale con il momento storico. Semmai si potrebbe obiettare che Nicchiarelli sia ricorsa a questa arguta strategia con eccessiva parsimonia, per cui la caratterizzazione punkettara risulta essere più un fatto episodico e relegato ad alcuni singoli momenti, che non una caratteristica costante di Eleanor, ma probabilmente risponde ad una sua precisa intenzione registica.

È complesso addivenire ad un giudizio univoco su questa opera che presenta ragioni di grande forza cinematografica e motivi di debolezza dall’altro. È vero infatti che Nicchiarelli non sorprende dal punto di vista della tipologia generale del film, che confina entro i limiti di un biopic piuttosto convenzionale per concezione e modalità di sviluppo. Ed è altrettanto vero però che, trattandosi di un biopic convenzionale, ma di qualità elevatissima, tutta la componente scenografica della ricostruzione storica, della riproduzione ambientale come dei costumi, è di magistrale fattura, curatissima nel dettaglio e filologicamente accurata. Inoltre in questo suo pedinare la vita di Eleanor vagamente pedissequo la Nicchiarelli consapevolmente sceglie di incentrare quasi tutto il film gli aspetti del privato sentimentale, dando vita ad un melò che decisamente lascia in secondo piano la rappresentazione della vicenda politico rivoluzionaria di questo personaggio carismatico. Le scene in fabbrica come quelle dei comizi o quella del piccolo mendicante straccioso che guida Eleanor sino al giaciglio di una madre piagata e in fin di vita sembrano infatti più appese, meno inserite nel coeso tutt’uno del resto del film e attaccate al solo scopo di rammentare quella marca eversiva e politica che altrimenti andrebbe smarrita. D’altro canto, sempre per ragioni che riguardano la fedeltà stretta al dettato biografico, la Nicchiarelli sceglie programmaticamente di non abbellire il personaggio attraverso espedienti filmici, consapevolmente non ne accentua la poeticità o la drammaticità attraverso scelte di ripresa, montaggio o scrittura, col risultato di ottenere una creatura che forse è meno dirompente sotto il profilo dell’emozione che suscita di quanto avrebbe potuto essere, meno potente e indimenticabile. D’altro canto questa è una considerazione da prendere con le molle nella misura in cui non posso escludere che risenta dell’inconscio paragone con lo struggente Nico 1988, che in fatto di decadente poeticità audiovisiva non ci andava certo leggero. Bisognerà poi dire anche che la scelta di concentrarsi più sul melò della vicenda sentimentale che sugli aspetti della Eleanor attivista
finisce con l’essere funzionale alla messa in scena di un’altra componente di questa complessa storia umana, quella secondo cui anche il privato diventa campo per una battaglia di emancipazione trasversalmente politica. «sconfiggere La tirannia dell’uomo sulla donna» questo è uno degli obiettivi che la lotta per la parità nella sfera sociale ed economica proietta sul privato dei singoli, nel loro quotidiano trascorrere entro le mura domestiche. È impossibile secondo questo tracciato concettuale, praticare una politica sociale ed economica realmente libertaria e paritaria in ambito pubblico se prima questa non viene concretamente applicata al nostro sistema di rapporti privato. La liberazione della massa dei lavoratori preliminarmente passa dalla liberazione che sapranno produrre nel loro privato. Ma è proprio questa la battaglia che è Eleanor, trionfatrice di mille cause in ambito pubblico, non riuscirà a vincere mai, sempre vincolata al suo morboso amore sbagliato e degradante, e la Nicchiarelli, focalizzando
l’attenzione del film sugli aspetti di questo privato fallimentare cerca di snidare la parte più delicata e dolorosa, il nervo più sensibile, di questa personalità complessa e combattiva. Un’opera complessa e stratificata, quindi, che reclama una ulteriore e chiarificatrice visione.