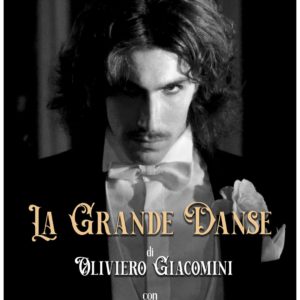L’analisi Stilistica
Nei programmi didattici di Action Academy l’analisi stilistica, la riflessione ragionata e analitica sui processi di significato che stanno alle spalle delle scelte di registi e montatori in fatto di modalità dell’inquadratura, di montaggio e fotografia, di direzione degli attori e di tutti quegli altri parametri di immagine e fotografia che messi insieme definiscono l’orizzonte estetico di un film o di una serie, occupa una posizione di tutto rispetto.
Nel contesto del programma di studi di Creatività e Produzione rientra anche l’analisi che segue, avente per oggetto la serie AMC The Walking Dead e incentrata sulla disamina di alcune problematiche di linguaggio e stile in relazione alla questione della serialità e dei suoi tempi lunghi.

Uno Stile Inconfondibile
Certamente tra le molte ragioni che rendono “speciale” The Walking Dead per migliaia di persone, che glielo rendono diverso da altri prodotti, oltre alla trama e ai personaggi, c’è il suo inconfondibile stile cinematografico. Quei suoi montaggi rapidi, i suoi primi piani dei non morti, la sua fotografia, il suo modo di raccontare le storie, un certo tipo di musica e un certo modo di utilizzarle durante le scene, insomma tutto ciò che costituisce l’ormai riconoscibilissima confezione stilistica della serie. Una formula vincente, che con variazioni trascurabili, ha saputo attraversare molteplici stagioni della serie riuscendo sempre a coniugare la massima linearità e chiarezza della narrazione a una componente altamente spettacolaristica e a una componente emozionale forte, fatta di colpi di scena continui e forti passioni.
Da un lato è indubbio che un prodotto come questo necessiti di una spiccata riconoscibilità stilistica che funzioni da cifra identificativa rispetto ad altre serie e sia in grado di costituire una ragione di attrattiva nei confronti del potenziale spettatore, che sedotto da un’estetica più accattivante e unica, dovrebbe essere indotto a scegliere questo e non altro prodotto analogo. A questo si aggiunga che le caratteristiche stilistiche di una serie producono “assuefazione ” perché nel tempo lo spettatore continuativo svilupperà una sorta di abitudine-affezione per quel tipo di immagine, per quei tempi, ritmi e modi della narrazione visiva, affezione che sul lato pratico è una ragione di fidelizzazione dei “fans” di importanza non inferiore all’interesse per la trama o all’affetto per i personaggi e per gli attori.
La“formula”: la riconoscibilità stilistica e il problema della durata
Ovviamente poi era necessario creare una omogeneità nel mondo rappresentato, così come nelle qualità della sua messa in rappresentazione, di modo che si potesse far transitare lo spettatore da un episodio all’altro, da una stagione a quella successiva o dalla mano di un regista a quella di un altro senza che se ne rendesse conto, senza che avvertisse differenze o discontinuità che gli rendessero meno credibile la narrazione. Va da sé che la soluzione più efficiente per soddisfare tutte queste istanze era quella di trovare una “formula”, un insieme di soluzioni stilistiche e narrative che con il loro ricorrere ripetuto creassero questa omogeneità, questa identità stilistica ben riconoscibile e fluidamente continua.
Ovviamente, non c’è nulla di male: è una delle strategie di identificazione e fidelizzazione più sfruttate dalle produzioni seriali per le quali, anzi, sviluppare un’identità stilistica personale e ben riconoscibile è un modo fondamentale di distinguersi da altri prodotti analoghi.
Inevitabilmente, però, The Walking Dead sconta gli effetti di una programmazione dalla durata considerevole: 10 stagioni di 16 episodi ciascuna non sono certamente una misura facile da sostenere con originalità sempre rinnovata, e la consuetudine stilistica, poco alla volta, nel succedersi delle stagioni, si è trasformata in eccessiva prevedibilità.
Tutto ormai avviene secondo modalità stilistiche consolidate e dalla comprovata efficacia, che lo spettatore ben conosce, e rispetto alle quali esercita un grado elevato di prevedibilità.

Si tratta di una scelta che garantisce un grado elevato di comprensibilità delle situazioni messe in scena, perché non lo pone mai di fronte a problemi di interpretazione o a complicazioni di sorta che in qualche misura possano derivargli da inconsuete modalità del trattamento stilistico, di modo che tutte le sue risorse di attenzione possano essere focalizzate sugli sviluppi della storia e sulla adesione emozionale alle situazioni che propone, anziché sulle inattese variazioni estetiche della forma filmica.
Lo spettatore senza stupore
Ad ogni scena di conflitto con i vaganti questo spettatore profeta ormai sa che il montaggio si farà più rapido e convulso, la visione sobbalzante ed agitata, ha la certezza matematica che a tratti l’obiettivo della macchina da presa si getterà addosso del corpo del non morto regalandogli dettagli splatterosi della sua carne putrefatta, conosce a memoria il sonoro fatto di rigurgiti, e vocalizzi strozzati che immancabilmente accompagna queste scene.
Ad ogni nuovo episodio ci attendiamo l’ormai ben nota struttura di montaggio alternato che mostra le vicissitudini di diversi gruppi di personaggi, “switchando” continuamente la narrazione tra l’uno e l’altro, per forza d’abitudine, perché The Walking Dead si racconta da sempre in questo modo. Lo spettatore, ormai sa bene che tipo di immagini, che fotografia, che recitazione aspettarsi, conosce e prevede ogni aspetto stilistico perché col tempo “la formula” che governa TWD ha imparato a conoscerla almeno quanto i suoi sceneggiatori e i registi. Uno spettatore che non si trova mai di fronte a un imprevisto, il che è certo un bene, se con questo intendiamo che non viene disturbato nel suo processo di immersione nella storia da arzigogoli stilistici in eccesso, ma che diventa un impoverimento, se consideriamo l’imprevisto nella sua accezione di sorpresa, stupore, meraviglia.
Il cinema e il senso di meraviglia
Ci sembra, cioè, che sia venuto meno nel tempo, vuoi per l’assuefazione dovuta all’abitudine vuoi per un consapevole indirizzamento stilistico voluto dalla produzione, il senso della “sorpresa” e della meraviglia che ti possono derivare da una soluzione di montaggio inconsueta, da un’immagine che non ti aspettavi e ti emoziona, piuttosto che da un qualcosa nella fotografia o nei cromatismi, nella recitazione o nel suono che anche solo per un breve istante ti fa tra salire. La reiterazione della formula precodificata, che pure è indispensabile nel fornire omogeneità e una forte identità al prodotto, ha finito per soffocare la componente inventiva del linguaggio filmico, la possibilità di far scaturire da una scelta imprevista quel senso di meraviglia che è proprio dello spettacolo cinematografico, che ne è l’essenza, e che nelle serie iniziali, forse anche per la novità che rappresentavano, si percepiva molto più forte, con scarti stilistici più accentuati.
Scrittura semplificata, base di consenso allargata
Alla percezione di questa “diminutio” del coefficiente di stupore cinematografico contribuisce anche una precisa operazione di comunicazione voluta dalla produzione, che negli anni ha continuamente mirato ad allargare la base di consenso a fasce di pubblico sempre più esteso e generalista. Ma un pubblico più vasto è anche un pubblico più eterogeneo, con gradi di maturità intellettiva, capacità di comprensione, competenze cinematografiche assai diversificate al suo interno. Si è dunque palesata, come conseguenza diretta, la necessità di adottare modalità di trattamento filmico sempre più alla portata di tutti, tali da non mettere in difficoltà nemmeno le fasce meno preparate e specializzate di questo pubblico allargato. Negli anni, quindi, si è fatto ricorso a soluzioni di scrittura e drammaturgiche sempre più semplificate e stereotipiche, che permettessero però una aumentata facilità di comprensione delle situazioni filmiche e della natura dei personaggi.
Con sempre maggiore frequenza si sono viste situazioni in cui gli sceneggiatori hanno voluto premere l’acceleratore sul pedale dell’effetto melodrammatico un po’ scontato e lacrimevole, mentre i personaggi sono diventati meno sfaccettati, compresi più che altro nei ruoli stereotipi dell’eroe positivo o del cattivo assoluto.
I personaggi stereotipi
Alfa e Beta, leader dei Sussurratori, che sono un buon esempio di questa recente dimensione scritturale della serie, sono incarnazioni bidimensionali, prive di qualsiasi contraddizione o complessità di un male semplicisticamente assoluto. La sceneggiatura non li dota di alcuna psicologia, di qualsivoglia sfaccettatura: sono solo cattivi, disgustosamente cattivi e ben lontani da quella complessità e ricchezza interiore che era stata una delle cifre contraddistintive degli albori di questa serie. Shane (Jon Bernthal), il primo avversario-amico di Rick era una costruzione complessa, ricca di sfaccettature e contraddizioni, come d’altronde è l’umana natura nella realtà, dilaniato da conflitti interiori, egoista, ma spesso giustificato dalle circostanze, altruista sino all’inverosimile, preda dell’ira e del senso di vendetta, ma anche amico leale, uomo innamorato, spietato assassino, e così via, in un caleidoscopio di caratterizzazioni che non sempre e non necessariamente, come capita invece nelle stagioni recenti, ne consentiva una univoca e semplice lettura per lo spettatore. D’altronde ai suoi inizi The walking Dead era una serie in un certo senso di nicchia, un piccolo cult per cinefili amanti dell’horror o per super nerd esperti in serie d’oltreoceano, un pubblico “competente” sotto il profilo cinefilico, che richiedeva un minor grado di linearizzazione e stilizzazione di situazioni e personaggi, rispetto a quello allargato e meno competente che avrebbe acquisito in seguito.
Personaggi contrastati del tempo che fu
Personaggi che suscitavano impressioni talvolta contrastanti, buoni con spigolature di cattiveria, eroi con screziature di vigliaccheria o debolezza: umani ritratti nella loro contraddittorietà. Lo stesso Rick (Andrew Lincoln), nel suo ruolo di leader ed eroe della serie, prima di venire appiattito nello stereotipo quasi messianico di salvatore e pacificatore assoluto, sempre buono e saggio, aveva goduto di una complessità di scrittura che ce lo rendeva meno semplice da comprendere. Un antieroe spesso minato nella sua leadership da debilitanti cadute e sconfitte, a tratti incredibilmente coraggioso, sicuro nell’agire, duro, secondo i crismi dell’eroismo classico, a tratti invece spaventato, psicologicamente impreparato, debole, incapace di sostenere il proprio ruolo per intere stagioni della serie. Il tentativo di mettere in scena “un uomo”, con tutte le sue contraddittorietà, e dunque anche con tutte le difficoltà di giudizio che questa natura disomogenea comporta.
Inizialmente ci è voluto un po’ a Rick per emergere tra gli altri personaggi e affermarsi nel suo ruolo di leader e protagonista carismatico della serie, specialmente perché il suo oppositore Shane aveva analoghe doti da capobranco e un’umanità tracimante di sentimenti, che spesso ce lo hanno fatto amare, perfino preferire a Rick, in certi episodi. E una volta divenuto per tutti l’ eroe della serie quante volte abbiamo dovuto dubitare delle sue doti positive, come quando cedendo al desiderio di vendetta ammanetta Merle (Michael Rooker), il fratello cattivissimo e odiosissimo di Daryl, a una tubatura lasciandolo preda degli zombies, e quante volte la sua scorza da eroe è stata incrinata dall’incertezza, come durante il conflitto con il Governatore (David Morrissey), e quante le sue battaglie perse, le sue manifestazioni di debolezza. Un eroe che abbiamo visto dubbioso e sofferente, psicologicamente debilitato e fragile (soprattutto nelle puntate successive alla morte della moglie), dotato quindi di una contraddittorietà e una varietà di sfaccettature interiori che ce lo rendevano meno lineare e coerente, quindi meno semplice da interpretare, ma infinitamente più vivo, più simile a una persona reale che a un ruolo da eroe televisivo.

La nuova direzione in cui si è andati, invece, è stata quella di favorire la linearità della comprensione rispetto alla complessità della vita, scrivendo caratteri meno contraddittori e stratificati ma che permettessero ad un pubblico allargato, magari anche meno maturo e strutturato in quanto a comprensione dei film, una interpretazione univoca e priva di incertezze delle loro caratteristiche dominanti di personaggio positivo o negativo.
Situazioni semplificate e il “last minute rescue”
Una ricerca di linearità che inevitabilmente riguarda anche la complessità (e la credibilità) delle situazioni messe in sceneggiatura, che sono diventate rappresentazioni un po’ semplificate dell’eroismo, dell’amicizia, dell’appartenenza al gruppo, che però hanno il vantaggio di offrire allo spettatore una interpretazione immediata, da potersi fare “in corsa” durante la visione e senza richiedere riflessioni complesse da svolgersi a posteriori. I personaggi positivi, le loro scelte e comportamenti, godono di un nitore assoluto, li vediamo sempre pronti a sacrificare la propria vita, anzi, in questo spesso fanno a gara, per salvare i compagni, e costantemente colti dall’incomprensibile smania di offrirsi come volontari ogni volta che le necessità impongono una missione suicida o una impresa senza vie di scampo. Manifestazioni semplificate e intuitive di un eroismo un po’ a modico prezzo.
In queste scene gli sceneggiatori fanno largo ricorso luoghi comuni cinematografici un po’ stantii ed abusati, ma di comprovata efficacia e semplicità di comprensione, come lo stereotipo del compagno eroico che decide di restare indietro, auto condannandosi a una fine orribile per consentire agli altri di fuggire, o il “last minute rescue”, la classica struttura del salvataggio in extremis, che qui viene impiegata con straordinaria frequenza e spesso sulla base di concomitanze cronologiche un po’ poco credibili (i buoni che, guarda caso, arrivano sempre proprio nel preciso istante in cui il compagno di turno sta per essere azzannato, ferito, o decapitato, senza arrivare mai un minuto prima, quando la tensione della scena non è ancora al massimo, né mai un minuto dopo, quando sarebbe troppo tardi).
TWD 10×16: qualche esempio
Solamente in questo sedicesimo episodio di esempi del genere ne possiamo contare diversi. Carol ingaggia una vera e propria gara con Lydia per chi dovrà sacrificarsi facendosi seguire dall’orda dei non morti sino a gettarsi da un’alta scogliera, trascinandosi dietro l’orda. Il livello di scrittura delle battute è semplificato sino ai limiti dell’ingenuità e i toni si fanno un po’ melodrammatici: «Devo farlo io, so come farlo, posso farcela!» attacca Lydia e Carol, poco dopo: «Vai…questa è una mia scelta…qui finisco io», ma quando sta per buttarsi, con l’immancabile last minute rescue Lydia la trattiene per una mano e la salva, svelando la gratuità di questa piccola gara all’eroismo, visto che gli zombi, una volta indirizzati verso il burrone e continuando a camminare vi cadono da soli per inerzia, senza bisogno del sacrificio di chicchessia.
E similmente si svolge l’avventura di Gabriel, che sceglie di restare indietro per rallentare i nemici e consentire agli altri di mettersi in salvo con uno scambio di battute il cui senso melodrammatico è accentuato dal fatto che avviene con la piccola Judith, emblema vivente dell’innocenza e dell’infanzia indifesa, «Dovete andare via tutti, subito!!» e Judith teneramente rattristata: «Tu non vieni?»: «qualcuno deve impedirgli di tagliare la fune….» risponde Gabriel col fare solenne dell’eroe che si vota al sacrificio. Una manifestazione di eroismo che poi la sceneggiatura non sostiene, visto che il suo tempo di resistenza all’assalto dei Sussurratori sarà praticamente pari a zero, ma che fornisce lo spunto per un clamoroso last minute rescue, perché, proprio nel preciso istante in cui un Sussurratore stava per calargli addosso una grossa lama, guarda caso non un istante prima e non uno dopo, fanno irruzione Maggie e i suoi compagni, appena sopraggiunti, che in poche e micidiali mosse sgominano il gruppetto dei cattivi.

Situazioni un po’ semplificate, come dicevamo, si pensi a quanto è repentino e non del tutto giustificato sul piano della costruzione psicologica del personaggio il passaggio di Negan dalla parte dei buoni, che però permettono di accentuare gli aspetti emotivi della vicenda utilizzando rappresentazioni dei sentimenti già stereotipate da tanto cinema e quindi di facile assimilazione da parte di chi guarda.
Per essere obiettivi bisogna però considerare il anche fattore longevità: probabilmente, infatti è proprio l’interminabile durata della serie, a rendere più manifesto e annoiante quel ricorso alla formulaicità e alla stereotipia che in fin dei conti rientra del Dna di qualsiasi prodotto seriale, ma che sulla distanza breve, sul numero limitato di stagioni, si dissimula meglio. La causa del disagio che si prova guardando The Walking Dead, forse, è da imputarsi più al tempo che non al lavorio di sceneggiatori e montatori. Ma al di là d’ogni possibile elucubrazione di ordine filmologico e stilistico a parlare, e a confermare l’efficacia di questa straordinaria formula che è TWD, sono gli esorbitanti risultati commerciali e di popolarità raggiunti dalla serie, che pur con tutte le semplificazioni e le diminuzioni di cui abbiamo discusso, o forse proprio grazie a queste, si riconferma ancora una volta una delle realtà di punta nel campo del consumo internazionale di prodotti di intrattenimento audiovisivi, un vero e proprio “must see” di planetaria diffusione.Non resta che tuffarsi a capofitto in questo episodio 10×16 e nelle altre novità provenienti dalla filiera creativa targata TWD, Action Academy vi augura una buona visione.